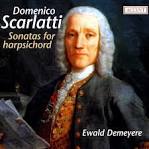 Pubblicato sul manifesto il 16 dicembre 2014 –
Pubblicato sul manifesto il 16 dicembre 2014 –
Ogni tanto sentiamo il bisogno di “staccare” un po’ dagli assilli quotidiani. Specialmente se per mestiere, consuteudine, antica vocazione – come nel mio caso – ci occupiamo di questioni attualmente generatrici di sentimenti abbastanza depressivi: le vicende della politica, per esempio. O la lettura dei quotidiani che ci parlano di una onnipresente violenza: orrendi delitti familiari, poliziotti che uccidono e torturano, guerre e attentati terroristici, donne violentate e assassinate, corruzione e minacce nell’attività amministrativa… Ci chiediamo se siamo spettatori di un reale aumento della violenza oppure se sia mutato qualche profondo meccanismo simbolico che ce la fa vedere ovunque. Anche laddove forse era sempre esistita ma non si manifestava al nostro sguardo in questo modo angosciante.
Da un po’ di tempo mi rifugio, quando posso, in un meraviglioso altrove, un universo costituito dalle 555 sonate per tastiera composte da Domenico Scarlatti nei primi decenni del ‘700. Ero ancora un ragazzo quando scoprii questo magico mondo, grazie alle esecuzioni al pianoforte, su un bel vinile, di Vladimir Horowitz. Oggi su youtube si può ascoltare credo tutto il corpus, spesso seguendo le interpretazioni su riproduzioni dello spartito.
Scarlatti nacque a Napoli, figlio d’arte (il padre Alessandro è stato un altro genio del barocco italiano, ma direi superato dal figlio), nel 1685. Anno magico per la musica, lo stesso di Bach e di Haendel.
Nello schema di questi pezzi si ripetono diverse costanti formali e compositive, ma la caratteristica fondamentale è una ricchezza incredibile di invenzioni armoniche, ritmiche, timbriche, melodiche. L’arte musicale stava abbandonando le tradizionali e sacre simmetrie polifoniche per votarsi alle modalità profane e popolari, in cui la melodia è sostenuta dagli accordi dell’accompagnamento, e nei ritmi ternari si evocano danze aristocratiche o paesane.
Tutto questo lo ritroviamo nelle geniali sonate di Scarlatti, ma ogni tanto, con una certa regolarità, ci imbattiamo in capolavori basati sul contrappunto. Fughe non meno elaborate di quelle di Bach e Haendel. Altre composizioni in cui l’intreccio delle singole voci contrapposte produce una straordinaria armonia parlante, capace di toccare vertici di intensità espressiva.
Ascoltando questa musica ho ripensato a quanto scriveva Edward Said a proposito della non solo possibile ma necessaria convivenza tra identità e culture diverse, che così spesso precipitano invece nella contrapposizione violenta e distruttiva. Da appassionato e profondo conoscitore della musica Said utilizzava proprio il concetto di contrappunto per rilevare come le identità culturali non siano “essenze date”, anche se esercitano un fascino perché sembrano tali, ma rappresentino invece “insiemi contrappuntistici, poiché si da il caso che nessuna identità potrà mai esistere per se stessa e senza una serie di opposti, negazioni e opposizioni” (E. Said, Cultura e imperialismo).
E in un altro testo, parlando dell’arte di Glenn Gould, Said osservava come fosse ineguagliabile la sua capacità di restituire tutta la complessità e la godibilità del gioco contrappuntistico della musica di Bach, eseguendo ogni singola voce in ogni singolo istante del suo risuonare ora accanto ora contro le altre voci della partitura.
Così, anche fuggendo per un momento in una più gradevole realtà parallela, si inciampa di nuovo nelle preoccupazioni quotidiane. Si fantastica sulla probabile utilità di lezioni di contrappunto a chi ha qualche potere di influire sui destini del mondo.
 Follow
Follow